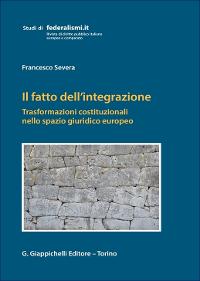Log in or Create account
FOCUS - Osservatorio sul diritto elettorale
Elezioni Tunisia 2024: Un risultato atteso in una (nuova) transizione costituzionale?
Lo scorso 6 ottobre 2024 si sono tenute le elezioni presidenziali in Tunisia. Queste sono state le prime celebratesi dopo la riforma costituzionale promossa dal presidente uscente Kais Saied, approvata dal referendum popolare del 25 luglio 2022 con il 94,6% dei voti favorevoli, ma con un’affluenza che si è fermata intorno al 30%.
La nuova Costituzione, che ha sostituito quella del 2014, ha rimosso i numerosi meccanismi di pesi e contrappesi tipici delle carte più democratiche, muovendosi nella direzione di un rilevantissimo accentramento di potere nelle mani del potere esecutivo, sul quale ricadono anche prerogative di natura legislativa e giurisdizionale. In tale contesto, si è assistito alla sospensione e al successivo scioglimento del Parlamento, nonché della destituzione del governo Mechichi, a seguito della proclamazione dello stato di eccezione previsto dall’art. 80 della Costituzione tunisina. A ciò si aggiunga che, durante il suo primo mandato, Kais Saied ha impedito l’istituzione della Corte Costituzionale, ha sciolto nel febbraio del 2022 il Consiglio Superiore della Magistratura, così come è intervenuto profondamente sulle modalità di composizione dell’Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (ISIE).
Tra il 2022 e il 2023 sono state, inoltre, modificate anche le norme in materia elettorale, a cominciare da quelle di rango costituzionale. Infatti, il novellato art. 89 prevede che un candidato alla presidenza debba non solo essere di cittadinanza tunisina, ma deve anche dimostrare di essere nato da padre e madre tunisini, nonché di avere nonni paterni e materni, anch’essi sempre di nazionalità tunisina. A ciò si aggiunge il requisito del pieno godimento dei diritti civili e politici e le previsioni che richiedono l’assenza di condanne penali per alcuni tipi reati, tra cui quelli elettorali.
Tuttavia, relativamente all’ultima misura, è stato notato come molti oppositori di Saied siano stati arrestati negli ultimi cinque anni, proprio in forza della normativa in materia. La riduzione dello spazio concesso alle opposizioni si è resa ancora più visibile quando, delle diciassette candidature presentate per le elezioni dello scorso 6 ottobre, solo tre sono state considerate ammissibili (nel 2019 erano ventisei). Ciò è avvenuto nonostante un intervento del Tribunale amministrativo, il quale aveva ordinato il reintegro di tre candidati, tra cui nomi di spicco della politica nazionale come Abdellatif Mekki e Mondher Zenaidi; la richiesta è stata, infatti, successivamente negata dall’ISIE, ponendo ulteriori dubbi sul grado di democraticità della tornata elettorale. In questa direzione, possono essere anche valutati i mancati accrediti concessi a giornalisti stranieri così come alle ONG per seguire le votazioni, come era, invece, avvenuto negli appuntamenti precedenti.
Dunque, dopo il vaglio dell’ISIE, i candidati alla presidenza sono stati Kais Saied, presidente uscente, Zouhair Maghazaoui, segretario del partito Echaab e Ayachi Zammel, imprenditore e vicino al partito liberale Tahya Tounes. Quest’ultimo, tuttavia, è stato sottoposto a detenzione preventiva a poche settimane dalle votazioni con l’accusa di aver falsificato le firme necessarie per la candidatura. Questo ha determinato l’avvio di numerosi procedimenti giudiziari a suo carico, conclusisi nel novembre 2024, con un totale di 35 anni di pena da scontare nelle prigioni tunisine.
Tornando alle votazioni, i risultati sono andati nella direzione attesa, ovvero una larghissima vittoria del presidente uscente che ha raccolto il 90,69% dei voti, mentre Maghazaoui e Zammel si sono spartiti le restanti preferenze, rispettivamente con l’1,97% e il 7,35%. L’affluenza attestatasi al 28,8%, dato più basso dall’inizio della transizione costituzionale del Paese, può essere letto come un ulteriore segnale che va nella direzione di un indebolimento della democrazia tunisina e di un allontanamento crescente tra cittadinanza e potere pubblico.
Il secondo mandato di Kais Saied si apre, così, in un momento di difficoltà per la Tunisia non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche socioeconomico con una crisi che continua ad attanagliare il Paese, seppur con alcuni dati in controtendenza, e un dialogo serrato tra il Presidente e gli organismi internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, che supportano il Paese e il suo debito pubblico.
In conclusione, i risultati emersi dalle elezioni del 6 ottobre scorso non possono che essere letti come un ulteriore rafforzamento dell’attuale sistema politico tunisino, ma probabilmente non delle sue istituzioni democratiche. Questo evidenzia non solo la peculiare traiettoria assunta dal Paese nordafricano in seguito alle proteste della cosiddetta primavera araba, ma può interrogarci in modo più ampio sulle transizioni costituzionali, sulle loro peculiarità, le loro fragilità e i loro tempi, dentro e oltre il contesto mediterraneo.
NUMERO 10 - ALTRI ARTICOLI
-
ITALIA - DOTTRINA
La legge oscura: come, quando e perché
ITALIA - DOTTRINARegolazione UE e stato di diritto di fronte ai cambiamenti geopolitici
-
ITALIA - DOTTRINA
Sinossi e spunti critici in tema di indirizzo politico della difesa nella forma di governo parlamentare
ITALIA - DOTTRINARe-thinking Youth Participation for Environmental and Climate Issues
ITALIA - DOTTRINAEmergenza educativa e “scuola etica” in Italia. Profili costituzionali
-
ITALIA - DOTTRINA
La nuova disciplina veneta degli ATS



 Registrati
Registrati Login
Login
 Territorio e istituzioni
Territorio e istituzioni Lavoro Persona Tecnologia
Lavoro Persona Tecnologia America Latina
America Latina Africa
Africa Osservatorio di Diritto sanitario
Osservatorio di Diritto sanitario Osservatorio sul diritto elettorale
Osservatorio sul diritto elettorale Osservatorio Trasparenza
Osservatorio Trasparenza Human Rights
Human Rights Storico focus
Storico focus Riforme istituzionali e forma di governo
Riforme istituzionali e forma di governo
 STUDI FEDERALISMI
STUDI FEDERALISMI