
Log in or Create account
FOCUS - Le società partecipate al crocevia N. 6 - 16/11/2018
I poteri speciali esercitabili da parte dell'Esecutivo
Il decreto-legge n. 21 del 2012 ha stravolto l’impianto normativo della c.d. golden share, ridisegnando ex novo i poteri speciali che lo Stato può esercitare per condizionare, rallentare e, in ultima istanza, impedire acquisizioni di partecipazioni societarie, da parte di soggetti esteri, nel capitale di imprese strategicamente rilevanti e operanti in settori “sensibili”, segnatamente la difesa e la sicurezza nazionale nonché l’energia, i trasporti e le comunicazioni.
L’obiettivo del legislatore della riforma è stato quello di apprestare una intelaiatura legislativo-regolamentare che, se per un verso non comprimesse eccessivamente la libertà di azione dello Stato nel salvaguardare gli asset più strategicamente rilevanti per il Paese (indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, di tali asset), per altro verso risultasse rispettosa dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea e, in particolare, di alcuni suoi principi cardine, quali il diritto di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei capitali (secondo l’interpretazione fornitane nel corso degli ultimi anni da parte della Corte di giustizia dell’UE): non è certo un mistero, difatti, che il succitato decreto-legge sia nato a seguito del deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea nell’ambito di una procedura di infrazione avviata da quest’ultima (peraltro appena otto mesi dopo che il nostro Paese era stato condannato dai giudici di Lussemburgo proprio a causa dell’impianto normativo e regolamentare allora vigente nel nostro paese in materia di golden share).
Il d.l. 21/2012 segna, sostanzialmente, un radicale mutamento di approccio da parte del legislatore, che rinuncia a utilizzare strumenti tipici del diritto societario (come, ad esempio, la previsione di clausole attributive di poteri speciali da inserirsi all’interno degli statuti delle singole società “bersaglio”) per porsi, al contrario, alla stregua di un regolatore che interviene ab externo in presenza di fenomeni di interesse e rilevanza generale. Ecco dunque che l’intervento statale (peraltro modulato differentemente a seconda dei singoli settori di volta in volta considerati) si sposta da quello che era un piano squisitamente soggettivo (interventi esercitabili solo nei confronti di determinate e specifiche società, prevalentemente quelle oggetto di privatizzazione) a un piano che, ora, è chiaramente oggettivo (poteri speciali azionabili indifferentemente verso qualsiasi società che svolga una determinata attività considerata particolarmente meritevole di “protezione”).
L’obiettivo del presente contributo è quello di analizzare, mettendone in luce le principali caratteristiche e criticità, l’intelaiatura normativa scaturita dal d.l. 21/2012 e dai numerosi decreti e regolamenti successivamente adottati da parte dell’Esecutivo, nonché operare una pur breve panoramica dei primi casi in cui la nuova disciplina ha trovato concreta applicazione, con particolare riferimento alle recenti vicende che hanno visto protagoniste TIM e Vivendi.
NUMERO 22 - ALTRI ARTICOLI
-
ITALIA - DOTTRINA
Arbitrato rituale e giurisprudenza costituzionale
ITALIA - DOTTRINAIl finto 'effetto Marx'. Resistibile ascesa, deriva keynesiana e irresistibile declino del marxismo giuridico italiano
-
ITALIA - DOTTRINA
I futuri rapporti tra le Corti dopo la sentenza n. 269/2017
ITALIA - DOTTRINAIndipendenza e imparzialità del magistrato fuori ruolo
-
ITALIA - DOTTRINA
La 'riserva' di amministrazione nella gestione del debito pubblico (dello Stato) e i conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale della Corte dei Conti.
ITALIA - DOTTRINALa dubbia legittimità dell'usucapione pubblica alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
ITALIA - DOCUMENTAZIONEI giudici amministrativi valorizzano il diritto alla sicurezza giuridica



 Registrati
Registrati Login
Login
 Osservatorio di Diritto sanitario
Osservatorio di Diritto sanitario Osservatorio sul diritto elettorale
Osservatorio sul diritto elettorale Lavoro Persona Tecnologia
Lavoro Persona Tecnologia Osservatorio Trasparenza
Osservatorio Trasparenza Africa
Africa Human Rights
Human Rights America Latina
America Latina Territorio e Istituzioni
Territorio e Istituzioni Storico focus
Storico focus Riforme istituzionali e forma di governo
Riforme istituzionali e forma di governo Scarica il Documento integrale
Scarica il Documento integrale STUDI FEDERALISMI
STUDI FEDERALISMI
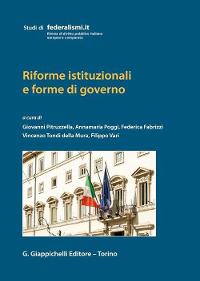




30/08/2024
29/07/2024
03/06/2024
15/03/2024
29/12/2023
04/08/2023
05/06/2023
30/01/2023
09/12/2022
28/10/2022
28/03/2022
02/02/2022
17/01/2022
12/02/2021
18/01/2021
13/11/2020
12/10/2020
17/06/2020
01/06/2020
18/05/2020
04/05/2020
24/04/2020
10/04/2020
27/03/2020
10/04/2020
25/10/2019
27/09/2019
15/04/2019
25/03/2019
14/01/2019
14/12/2018
16/11/2018
09/11/2018
14/09/2018
03/09/2018
22/06/2018
23/02/2018
27/11/2017
02/10/2017