
Log in or Create account
FOCUS - Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa N. 1 - 02/10/2017
La democrazia rappresentativa e l'Unione Europea
Il costituzionalismo moderno sta attraversando, attualmente, una delle crisi più gravi della sua storia, particolarmente avvertita in ambito europeo (ma non solo: si pensi alle recenti elezioni nordamericane), e che sembra implicare una seria minaccia al processo di civilizzazione che il costituzionalismo ha garantito all’umanità. In questa crisi sono coinvolte la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa, ma essa nasconde, più in profondità, il progressivo indebolirsi della stessa democrazia pluralista. Talvolta, questo indebolimento si è manifestato come crisi della democrazia rappresentativa, dando luogo allo sviluppo dei populismi e all’utilizzo in senso demagogico degli strumenti della democrazia diretta come il referendum. Così può essere descritta, ad esempio, la vicenda Brexit ma, a ben vedere, problemi simili si sono posti in relazione alle recenti elezioni presidenziali nordamericane, che pure si iscrivono nella logica della democrazia rappresentativa. Per ciò che riguarda l’Unione europea, l’involuzione democratica sta mettendo seriamente a rischio un processo di civilizzazione che ha svolto funzioni storiche particolarmente rilevanti, specie in relazione al controllo e alla limitazione delle tendenze nazionalistiche che avevano condotto allo scoppio della seconda guerra mondiale. Simili tendenze, è bene ricordarlo, si ispiravano ad una concezione della democrazia basata sulla volontà illimitata e sovrana della maggioranza, in ambito interno, ciò che facilitò la nascita di regimi totalitari. Questi ultimi proiettarono all’esterno le proprie tendenze nazionaliste ed imperialiste, determinando il più aspro e spaventoso confronto bellico che la storia, finora, ricordi. Benché il progetto europeo si sia sviluppato, all’inizio, per così dire “alle spalle” del diritto costituzionale – caratteristica non positiva, perché ha condotto ad un modello di integrazione che non ha tenuto nella dovuta considerazione l’alto grado di sviluppo democratico raggiunto e garantito dalle Costituzioni normative - è altrettanto certo che il processo di integrazione abbia quantomeno contribuito alla limitazione del potere esterno degli Stati. In altri termini, l’integrazione sopranazionale ha condotto ad una progressiva ridefinizione della sovranità statale, configurando il potere dello Stato come un potere ormai assoggettato ai limiti derivanti dalla cooperazione con gli altri Stati europei. Allo stesso tempo, l’integrazione sopranazionale, per sua stessa natura, ha ridotto i possibili “spazi di manovra” del nazionalismo, delineando una convergenza tra le diverse nazioni europee, protagoniste di un progetto comune, capace a sua volta di dare vita ad una comune cittadinanza. Nonostante siano molte le critiche che possono essere rivolte – e che verranno anche in questo lavoro rivolte – al processo di integrazione, deve allo stesso tempo essere sempre ricordata la sua portata specifica in termini di civilizzazione, nella misura in cui esso è stato ed è fattore di limitazione del potere statale tanto all’interno, quanto all’esterno, così recuperando un tratto dello spirito originario del costituzionalismo. Se si osservano l’attuale deterioramento della democrazia in Europa, e il progressivo sviluppo, nel mondo, di progetti politici fortemente nazionalisti e sempre più aggressivi – nei quali si indebolisce la cultura costituzionale di rispetto delle minoranze e si esalta la dimensione del conflitto, sia tra le nazioni che all’interno delle società – è impossibile non manifestare preoccupazione, come costituzionalisti, per l’involuzione che sta attraversando, in maniera molto intensa, il progetto di integrazione europea. Certo, il progetto europeo vive sin dai primordi una tensione interna ancora irrisolta, e che è almeno in parte all’origine dell’involuzione degli ultimi anni. Da un lato, vi è la tendenza a debilitare la democrazia pluralista all’interno degli Stati, riducendo gli strumenti di controllo e limitando la responsabilità politica dei governi, nella misura in cui il conflitto politico interno è obliterato e, per così dire, trasformato nel conflitto di una intera nazione di fronte all’Europa. Simile tendenza impedisce la costruzione di una identità europea e rafforza gli Stati membri nel loro ruolo di protagonisti quasi esclusivi dello spazio pubblico europeo, favorendo l’apparire di nazionalismi disgreganti. D’altro, vi è una strutturale vocazione all’integrazione e alla confluenza delle diverse esperienze in uno spazio pubblico comune, la cui configurazione non può che essere democratica e costituzionale. Si tratta di una tendenza che rappresenta l’autentica maturazione del progetto europeo, e che dovrebbe condurre ad un’evoluzione di tipo federale, nella quale un’Europa “unita nella diversità” renda possibile ridurre il peso politico dei nazionalismi interni, rivitalizzando la democrazia interna nel contesto di una democrazia europea. Non è facile predire quale delle due tendenze appena delineate finirà per imporsi nell’inesausta tensione tra i due poli che hanno caratterizzato, storicamente, il processo di integrazione. Quel che è certo, è che l’Europa sta affrontando, in questa fase, la sua ora decisiva. L’attuale stato di crisi ha radici talmente profonde, che l’unica alternativa aperta è quella tra un sostanziale avanzamento del processo di integrazione o la progressiva decomposizione dell’Unione, sull’esempio di Brexit. Se si considerano le sfide della globalizzazione, non c’è dubbio che l’unica possibile via di uscita dalla crisi sia, per gli Stati europei, quella rappresentata da un avanzamento sostanziale nel processo di integrazione e nella costruzione di una Europa federale. Quale che sia il suo risultato, il processo sarà definito dalle attuali condizioni democratiche dell’Unione, con tutti i limiti ad esse connessi, e dalla proiezione di simili condizioni sui sistemi democratici statali. Pertanto, la questione della democrazia in Europa è anzitutto quella della sua configurazione strutturale, ma anche quella della possibilità di una sua evoluzione nel senso di un processo aperto, che – superando i suoi ben noti limiti – possa condurre ad un avanzamento nella costruzione democratica dell’Europa e, in conseguenza, ad un recupero della qualità della vita democratica all’interno degli Stati membri... (segue)
NUMERO 19 - ALTRI ARTICOLI
-
ITALIA - DOTTRINA
Corte Costituzionale e principio di 'lealtà' nella collaborazione tra Stato e Regioni per l'esercizio delle funzioni
ITALIA - DOTTRINAReligione e immigrazione nella prospettiva costituzionale
-
ITALIA - DOTTRINA
La valutazione parlamentare delle politiche pubbliche nella determinazione della forma di governo britannica: un'analisi di impatto
-
ITALIA - DOTTRINA
La funzione nomofilattica: profili interni e sovranazionali
ITALIA - DOTTRINAL'avvio del processo di convergenza e le prospettive di gestione del debito pubblico
ITALIA - DOTTRINALa designazione dei governanti



 Registrati
Registrati Login
Login
 Territorio e istituzioni
Territorio e istituzioni Lavoro Persona Tecnologia
Lavoro Persona Tecnologia America Latina
America Latina Africa
Africa Osservatorio di Diritto sanitario
Osservatorio di Diritto sanitario Osservatorio sul diritto elettorale
Osservatorio sul diritto elettorale Osservatorio Trasparenza
Osservatorio Trasparenza Human Rights
Human Rights Storico focus
Storico focus Riforme istituzionali e forma di governo
Riforme istituzionali e forma di governo Scarica il Documento integrale
Scarica il Documento integrale STUDI FEDERALISMI
STUDI FEDERALISMI
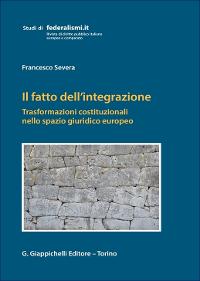




08/08/2025
30/05/2025
14/04/2025
24/01/2025
01/11/2024
30/08/2024
29/07/2024
03/06/2024
15/03/2024
29/12/2023
04/08/2023
05/06/2023
30/01/2023
09/12/2022
28/10/2022
28/03/2022
02/02/2022
17/01/2022
12/02/2021
18/01/2021
13/11/2020
12/10/2020
17/06/2020
01/06/2020
18/05/2020
04/05/2020
24/04/2020
10/04/2020
27/03/2020
10/04/2020
25/10/2019
27/09/2019
15/04/2019
25/03/2019
14/01/2019
14/12/2018
16/11/2018
09/11/2018
14/09/2018
03/09/2018
22/06/2018
23/02/2018
27/11/2017
02/10/2017