
Log in or Create account
FOCUS - Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa N. 1 - 02/10/2017
Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell'organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica
Il contesto attuale appare profondamente segnato dalla crisi della tradizionale rappresentanza politica alla quale si accompagna una evidente crisi dei partiti politici sotto il profilo della capacità di rappresentare le istanze provenienti dalla società e della loro legittimazione agli occhi dei cittadini. Questa crisi, peraltro, non riesce a trovare uno sbocco, o quantomeno un tentativo di risposta, nell’adozione di una legge organica di disciplina dei partiti politici che tenti di riannodare il filo del dialogo tra partiti e società civile. La crisi della rappresentanza politica e le difficoltà che deve affrontare il modello della democrazia rappresentativa nelle democrazie occidentali sono evidentemente connesse alle difficoltà di legittimazione dei partiti politici. I quali sono andati configurandosi sempre di più, a partire dalla seconda metà del Novecento e per mezzo delle Costituzioni rigide del Secondo Dopoguerra, come gli strumenti della rappresentanza. È attraverso i partiti politici che si rafforza il collegamento tra il popolo sovrano dell’art. 1 della nostra Costituzione ed il circuito decisionale Parlamento-Governo. Un collegamento che è generale e permanente e riguarda tutte le fasi del circuito rappresentativo, non riducendosi al momento del confronto elettorale. Se, dunque, i partiti hanno progressivamente assunto il ruolo fondamentale di cerniera, di trait d’union tra cittadini e autorità politica, è evidente che le dinamiche della rappresentanza sono influenzate dai sistemi partitici e dal funzionamento interno dei partiti. Il che porta a concludere che l’azione esterna dei partiti ma anche la loro organizzazione interna e, in particolare, il livello di democraticità dei partiti politici in relazione al loro funzionamento, è una variabile da tenere in considerazione anche alla luce del suo impatto sulla qualità della rappresentanza politica. Il ruolo di assoluto rilievo esercitato dai partiti politici nel funzionamento della democrazia rappresentativa delineato dalla Costituzione trova conferma nell’art 49 Cost. il cui impianto mette in rilievo anche la funzione attiva della società civile nel circuito rappresentativo: i cittadini mediante i partiti – che fungono pertanto da strumento della rappresentanza - sono chiamati a concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Non fosse altro che per queste brevi considerazioni iniziali, il tema dell’utilizzo del metodo democratico all’interno dei partiti politici appare centrale. La questione della democrazia nei partiti si pone, in particolare, in relazione ad alcuni aspetti del funzionamento di questa particolare tipologia di associazioni, quali, ad esempio: la selezione delle candidature per le elezioni; l’elezione delle maggiori cariche interne; la partecipazione degli associati al processo decisionale; i diritti dei singoli associati nel partito; le modalità di accesso ed iscrizione; le procedure di espulsione; la tutela delle minoranze interne. Se si pensa ad alcune delle vicende politiche degli ultimi anni si ricorderà che in diversi casi hanno riguardato conflitti interni ai partiti e, in particolare, gli aspetti appena richiamati relativi alla democrazia nei partiti. Questioni che sembrano porsi con sempre maggiore forza, tanto in relazione ai partiti più “tradizionali” che sono comunque in continua trasformazione e “scomposizione”, quanto al MoVimento 5 Stelle, nuovo movimento politico che è ormai da alcuni anni una delle maggiori forze politiche nel Paese. Le questioni “interne” ai partiti sembrano dunque esercitare un’influenza sempre maggiore all’”esterno”, nel circuito rappresentativo e, in particolare, sulla qualità stessa della rappresentanza politica. L’organizzazione interna di partiti e movimenti politici riguarda anche le modalità con cui viene data la possibilità di rendere effettivo, in concreto, quel diritto dei cittadini di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale contenuto nell’art. 49 Cost. Di realizzare quindi, in ultima istanza, il modello di democrazia rappresentativa che prefigura la nostra Costituzione. Una democrazia rappresentativa “mediata” dalla partecipazione diretta dei cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale attraverso i partiti e i movimenti politici. Il ruolo che l’art. 49 Cost. assegna ai partiti politici è anche finalizzato ad impedire uno dei principali effetti negativi della democrazia rappresentativa: il distacco tra rappresentante e rappresentato e la delega al rappresentante di tutte le decisioni. Allo stato attuale, la dottrina giuspubblicistica italiana sembra convergere sull’opportunità di una disciplina legislativa relativa ai partiti politici. Allo stesso modo, pur considerando le oscillazioni della classe politica sul punto, si deve comunque registrare un progressivo e costante aumento, nelle ultime legislature, delle proposte di legge sulla regolamentazione dei partiti politici. A cui si aggiunge un altro dato oggettivo di indubbio rilievo: l’approvazione, per la prima volta nell’esperienza repubblicana, di un disegno di legge sui partiti presso la Camera dei deputati nel giugno 2016 e attualmente all’esame del Senato. In un contesto in cui, peraltro, il legislatore ha introdotto per la prima volta, a partire dal 2012, alcune norme riferibili all’organizzazione interna dei partiti e al contenuto dei loro statuti, anche se direttamente connesse alla questione relativa al loro finanziamento. Le ultime, pur incomplete, evoluzioni di questi anni rappresentano comunque un passo in avanti in un ambito in cui, tradizionalmente, il diritto pubblico si incrocia con il diritto privato, ma che, anche a causa della perdurante assenza di una disciplina legislativa sui partiti, ha sino ad oggi visto prevalere di gran lunga la dimensione privatistica in relazione alle norme di regolamentazione della vita dei partiti. Un altro aspetto da prendere in considerazione in via preliminare è collegato a questioni, per così dire, definitorie. Ci si riferisce alla domanda su che cosa si debba intendere per partiti politici. La questione si pone, in particolare, se si prende in considerazione il fenomeno recente della nascita di movimenti politici che, in aperta opposizione rispetto a ciò che rappresentano o hanno rappresentano i tradizionali partiti politici, si presentano davanti al corpo elettorale rimarcando una netta discontinuità, di più, una diversità genetica, rispetto a questi ultimi. A tale riguardo si ritiene, comunque, che possa rimanere sempre valida l’identificazione di un partito politico con un’associazione politica che si caratterizza per l’elemento – essenziale – della partecipazione alle competizioni elettorali. Tale questione terminologica, peraltro, va affrontata preliminarmente anche perché, attualmente, alcuni dei principali partiti politici italiani – Forza Italia; Lega Nord; MoVimento 5 Stelle – si auto-definiscono, all’interno dei propri statuti, movimenti politici... (segue)
NUMERO 19 - ALTRI ARTICOLI
-
ITALIA - DOTTRINA
Corte Costituzionale e principio di 'lealtà' nella collaborazione tra Stato e Regioni per l'esercizio delle funzioni
ITALIA - DOTTRINAReligione e immigrazione nella prospettiva costituzionale
-
ITALIA - DOTTRINA
La valutazione parlamentare delle politiche pubbliche nella determinazione della forma di governo britannica: un'analisi di impatto
-
ITALIA - DOTTRINA
La funzione nomofilattica: profili interni e sovranazionali
ITALIA - DOTTRINAL'avvio del processo di convergenza e le prospettive di gestione del debito pubblico
ITALIA - DOTTRINALa designazione dei governanti



 Registrati
Registrati Login
Login
 Territorio e istituzioni
Territorio e istituzioni Lavoro Persona Tecnologia
Lavoro Persona Tecnologia America Latina
America Latina Africa
Africa Osservatorio di Diritto sanitario
Osservatorio di Diritto sanitario Osservatorio sul diritto elettorale
Osservatorio sul diritto elettorale Osservatorio Trasparenza
Osservatorio Trasparenza Human Rights
Human Rights Storico focus
Storico focus Riforme istituzionali e forma di governo
Riforme istituzionali e forma di governo Scarica il Documento integrale
Scarica il Documento integrale STUDI FEDERALISMI
STUDI FEDERALISMI
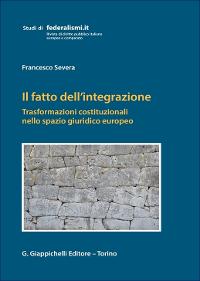




08/08/2025
30/05/2025
14/04/2025
24/01/2025
01/11/2024
30/08/2024
29/07/2024
03/06/2024
15/03/2024
29/12/2023
04/08/2023
05/06/2023
30/01/2023
09/12/2022
28/10/2022
28/03/2022
02/02/2022
17/01/2022
12/02/2021
18/01/2021
13/11/2020
12/10/2020
17/06/2020
01/06/2020
18/05/2020
04/05/2020
24/04/2020
10/04/2020
27/03/2020
10/04/2020
25/10/2019
27/09/2019
15/04/2019
25/03/2019
14/01/2019
14/12/2018
16/11/2018
09/11/2018
14/09/2018
03/09/2018
22/06/2018
23/02/2018
27/11/2017
02/10/2017